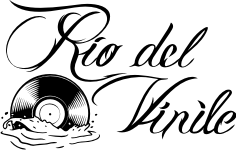La cena comprendeva
oca, pollo, pernice, carne di cervo e un orribile vino rimasto troppo
a lungo nelle cantine dopo essere giunto in Britannia. Terminato il
pasto, ci accomodammo sui divani e un’arpista suonò per noi.
I divani erano
mobili per le stanze delle donne: Galahad e io eravamo a disagio su
quei bassi sedili troppo imbottiti, ma io ero contento perché ero
riuscito a sedermi accanto a
Ceinwyn. Per un poco mi tenni dritto, poi mi appoggiai sul gomito per
poter parlare sottovoce con lei. Mi complimentai per il suo
annunciato matrimonio con re Gundleus.
Ceinwyn
mi lanciò un’occhiata ironica. «Sembrano parole da cortigiano»
disse.
«A
volte sono obbligato a trasformarmi in cortigiano, signora. Mi
preferiresti nei panni di guerriero?»
Anche
lei si appoggiò sul gomito, in modo che la nostra conversazione non
disturbasse la musica; per la sua vicinanza mi parve che i miei sensi
galleggiassero nel fumo.
«Il
mio signore Gundleus» disse sottovoce Ceinwyn «ha chiesto la mia
mano come contropartita per l’impiego del suo esercito nella prossima
guerra.»
«Allora
il suo esercito, signora, è il più prezioso della Britannia.»
Ceinwyn
non sorrise al complimento, ma continuò a guardarmi negli occhi.
«È vero» domandò a voce ancora più bassa «che ha ucciso
Norwenna?»
Fui
turbato da tanta franchezza. «Gundleus cosa dice?» replicai,
evitando una risposta diretta.
«Lui
dice» spiegò Ceinwyn con un mormorio che risultò quasi
impercettibile «che i suoi uomini furono assaliti e che nella
confusione Norwenna morì. Sostiene che si trattò di un
incidente.»
Lanciai
un’occhiata alla fanciulla che suonava l’arpa. Le due zie ci
guardavano con odio, ma Helledd non pareva preoccuparsi della nostra
conversazione. Galahad, un braccio intorno alle spalle del piccolo
Perddel già addormentato, ascoltava la musica.
«Quel
giorno, signora, ero nel castello dell’Isola di Cristallo» dissi,
rivolgendomi di nuovo a Ceinwyn.
«E
cosa accadde?»
Decisi
che la sua franchezza meritava una risposta altrettanto franca.
«Norwenna s’inginocchiò per dargli il benvenuto, signora, e
Gundleus le cacciò in gola la spada. L’ho visto con i miei occhi.»
Per
un istante, l’espressione di Ceinwyn si indurì. La luce tremolante
le bruniva la pelle chiara e lanciava ombre sulle sue guance e sotto
il labbro inferiore. La principessa indossava una ricca veste di lino
azzurro guarnita di pelliccia bianco argento con piccole macchie
nere, il manto invernale degli ermellini. Una torque d’argento le
circondava il collo e anelli d’argento le pendevano dalle orecchie.
L’argento s’intonava alla perfezione al colore dei suoi
capelli.
Emise un breve
sospiro. «Temevo di dover ascoltare questa verità» disse. «Ma
sono una principessa e ciò significa che devo sposare non chi
voglio, ma chi più conviene al regno.»
Per
un poco girò la testa verso l’arpa, poi si sporse di nuovo verso di
me. «Mio padre afferma che questa guerra riguarda il mio onore. È
così?»
«Per
lui, signora, è così. Ma Artù rimpiange la ferita che ti ha
provocato, te lo posso assicurare.»
Ceinwyn
accennò a una smorfia. L’argomento era doloroso, ma lei non
riusciva ad abbandonarlo perché il rifiuto di Artù aveva cambiato
la sua vita più profondamente e tristemente di quanto non avesse
cambiato quella del mio signore. Artù aveva trovato felicità e
matrimonio, mentre lei era rimasta a patire i lunghi rimpianti e a
cercare le dolorose risposte che, evidentemente, non aveva trovato.
«Tu
capisci Artù?» mi chiese dopo un poco.
«A
quel tempo non lo capii, signora. Pensai che fosse pazzo. E, come me,
tutti gli altri.»
«E
ora?» domandò lei guardandomi negli occhi.
Riflettei
qualche istante. «Penso, signora, che per una volta in vita sua
Artù sia stato preda di una follia che non poteva dominare.»
«L’amore?»
Guardai
i suoi occhi azzurri e mi dissi che non ero innamorato di lei e che
la sua fibula era un talismano finito per caso in mano mia. Lei era
una principessa e io il figlio di una schiava.
«Sì,
signora» risposi.
«Capisci
quella follia?»
Non
vedevo più niente, solo Ceinwyn. Helledd, il principino, Galahad,
le zie, l’arpista, la sala, niente esisteva. Vedevo solo i grandi
occhi tristi di Ceinwyn, udivo solo i battiti del mio cuore.
«Capisco
che puoi guardare negli occhi una persona e renderti conto a un
tratto che la vita ti sarà impossibile senza di lei. Che la sua
voce può far saltare un battito al tuo cuore, che la sua compagnia
è tutta la felicità che potrai mai desiderare, che la sua assenza
ti lascerà orbato e perduto.»
Per
un poco Ceinwyn rimase in silenzio, si limitò a guardarmi con aria
perplessa.
«A
te, Derfel, è mai accaduto?» chiese infine.
Esitai.
Sapevo quali parole il mio cuore avrebbe voluto dire e sapevo anche
quali parole la mia condizione sociale mi avrebbe obbligato a dire;
ma un guerriero non prospera certo nella timidezza, pensai, e lasciai
che il cuore governasse la lingua.
«A
me non era mai accaduto, signora, fino a questo momento.»
Quelle
parole richiesero più coraggio di quanto non me ne fosse mai
servito per infrangere un muro di scudi.
Ceinwyn
distolse subito lo sguardo e si irrigidì; mi maledissi per averla
offesa, con la mia stupida goffaggine. Mi ritrassi sul divano, rosso
in viso, imbarazzato, mentre la principessa applaudiva l’arpista e
gettava qualche moneta d’argento sul tappeto, accanto all’arpa. Le
chiese di suonare il Canto di Rhiannon.
«Credevo
che non ascoltassi, Ceinwyn» disse sornionamente una delle zie.
«Ascolto, Tonwyn, ascolto e traggo grande piacere da tutto ciò che sento» replicò Ceinwyn.
Bernard Cornwell, Il re d’inverno (1995)