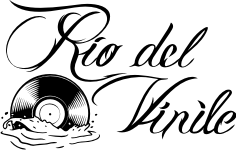Max Richter
The Blue Notebooks
2004
Accade che ascoltando The Blue Notebooks di Max Richter la suadente voce dell’attrice Tilda Swinton ci avvolga per sussurrare in un battere di macchina da scrivere:
When Thomas brought the news that the house I was born in no longer exists – neither the name, nor the park sloping to the river, nothing – I had a dream of return. Multicoloured. Joyous. I was able to fly. And the trees were even higher than in childhood, because they had been growing during all the years since they had been cut down.
È un attimo lasciarsi trascinare dall’immagine della distesa di alberi che ognuno di noi trattiene con sé senza avere la possibilità di poterla trasmettere se non attraverso parole, note come queste.
Ad ogni modo, incuriosito dal testo sono andato alla ricerca dell’autore, Czesław Miłosz: fortunatamente questa ed altre poesie sono edite in Italia da Adelphi. Non trovandola altrove la posto qui perché possa essere apprezzata come merita. Testo italiano a cura di Pietro Marchesani; dell’estratto trovo comunque preferibile la traduzione inglese.
Quaderno a parte: la Stella Assenzio
Ormai non c’è più nulla da perdere, mio prudente, mio scaltro, mio iper-egocentrico gatto.
Ormai possiamo confessare senza timore che se ne servano potenti nemici.
Siamo un’eco che corre con un leggero scalpitìo attraverso una fuga di stanze.
Si accendono e si spengono le stagioni ma come in un giardino che non frequentiamo.
Ed è un sollievo non dover cercare di uguagliarli, gli uomini, nella corsa e nel salto.
La terra di Vostra Altezza non piaceva.
Nella notte in cui è concepito un bambino viene stipulato un patto incomprensibile.
E un innocente riceve una condanna ma non riuscirà a capirne il senso.
Per quanto tragga auspici dalla cenere, dalle costellazioni e dal volo degli uccelli.
Un patto odioso, un groviglio nel sangue, l’anabasi di geni vendicativi da paludosi millenni,
Da ebeti, storpi, ragazze insane e re sifilitici,
Davanti a un coscio di montone e alla kasza e sorsando zuppa.
Battezzato con acqua e olio quando sorge la Stella Assenzio,
Giocavo sul prato vicine alle palatki della Croce Rossa.
L’ora assegnatami, come se non bastasse il destino privato.
In qualche piccolo posto fuor di moda (« Era appena suonata la mezzanotte sull’orologio del municipio, quando lo studente N. »… eccetera).
Come parlare? Come strappare la pelle alle parole?
Ciò che ho scritto mi sembra adesso non questo.
E ciò che ho vissuto mi sembra adesso non questo.Quando Tomas portò la notizia che la casa in cui sono nato non c’è più,
Né il viale, né il parco che scendeva al fiume, nulla.
Sognai il sogno del ritorno. Gioioso. Variopinto. Sapevo volare.
E gli alberi erano ancora più grandi di quando ero bambino, perché avevano continuato a crescere anche quando non c’erano più.
La perdita dei luoghi natìi e della patria,
L’errabondare tutta la vita fra popoli stranieri,Perfino questo
È solo romantico, ossia sopportabile.
D’altronde si è così realizzata la mia preghiera di studente ginnasiale educato sui vati: la richiesta di grandezza, cioè l’esilio.
La terra di Sua Altezza non è piaciuta
Per una ragione diversa da quella dello Stato universale.
Benché io sia stupito di aver raggiunto una rispettabile età.
E senza dubbio ho goduto di soccorsi miracolosi, per i quali ho giurato riconoscenza a Dio, ciò significa che quell’orrore ha visitato anche me.
Ode le voci, ma non comprende quei gridi, preghiere, bestemmie, inni, che lo hanno scelto per medium. Vorrebbe sapere chi era, e non lo sa. Vorrebbe essere uno, ed è una molteplicità in sé contraddittoria, che solo in parte gli causa piacere, ma soprattutto vergogna. Ricorda le palatki della Croce Rossa sul lago nella località di Wyzki (e non saprebbe chiamarle tende, se allora non le chiamavano così). Ricorda l’acqua svuotata dalla barca, le grandi onde grigie e la chiesa greco-ortodossa che sembrava emergere da esse. Pensa a quell’anno 1916 e alla sua bella cugina Ela in uniforme di infermiera, al suo percorrere a cavallo centinaia di verste della fascia lungo il fronte con l’avvenente ufficiale appena sposato. E la sua mammina con addosso uno scialle, siede al tramonto accanto al camino col signor Nekrasz, conosciuto quando studiava a Riga e le sue spalline scintillano. Ha disturbato la loro conversazione ma ora se ne sta seduto buono buono a rimirare le livide fiammelle, poiché lei gli ha detto che, se avesse guardato a lungo, vi avrebbe visto camminare un buffo omino con la pipa.
Che faremo del figlio della donna? Chiedono le forze
Sorvolando la terra. Le bocche da fuoco delle batterie
Saltano nel rinculo. Ancora. E là la pianura
Lampeggia fino all’orizzonte, brulica, corrono.
Nel parco sul lago le palatki ospedaliere
Vicino alle spalliere di siepi delle aiuole e dell’orto.
Adesso al galoppo. Ondeggia al vento il velo dell’infermiera,
L’impetuoso cavallo baio bruno, le stoppie, il fossato.
Dal cantiere di fluitazione sul fiume uomini dalla barba rossa remano.
Si spalanca oltre il fumo la svela schiantata.Il nostro sapere è modesto, dicono le forze.
Riconosciamo il loro dolore, ma senza averne pietà,
Ammiriamo la maestà, sotto le nuvole,
L’umiltà della Madre, della Sostanza, della Terra vergine.
E che ci importa delle vite, che ci importa del morire?Uscirono strisciando scarponi dalla trincea. Albeggia.
Lontano, sotto una gelida aurora, il treno blindato.Cammina, ma non per un bosco tremendo, a volte la fame soffrendo, ma per le stanze dove ribolle, luccica, brilla il colore e il suono delle forme una volta nate. Qui una schiera di zampognari catturati in un villaggio medievale si arrampica per una china erbosa sull’altopiano dove accompagnerà l’attacco, là la Wilia è straripata tanto da arrivare ai gradini della cattedrale e sotto l’intenso sole d’aprile le barchette pitturate a strisce azzurre, bianche e verdi si affaccendano intorno alla torre della cattedrale, là ancora i ragazzi raccogliendo i lamponi si sono imbattuti in un cimitero coperto di erbe coi nomi di Faust, Hildebrand. Davvero, che ci importa delle vite, che ci importa del morire.
Le signore dell’Anno Venti, che ci davano il cacao.
Accrescete la gloria della Polonia, piccoli cavalieri, aquilotti nostri!
Con gli amaranti abbottonati sotto il collo, i nostri alani entrano dall’Ostra Brama. Le signore del Circolo delle Polacche, le signore del P.O.W.Ho portato al museo i loro frac lamati d’argento,
Le tabacchiere degli oratori della camera dei deputati.
Gli zoccoli dei percheron picchiavano sull’asfalto,
Dalle strade vuote veniva un odore di putridume.
Buttavamo giù lo spirito a sorsi, noi carrettieri.« O madre dei ricordi, amante delle amanti ». Alla fermata dell’autobus andò a prenderlo Wladek col calesse. La strada era sconnessa e completamente deserta, sull’altopiano ventoso, brullo, in basso a destra un piccolo lago, più in là una lingua di terra: qui un occhio d’acqua posato sui prati verdi, là un’ampia superficie luccicante fra le colline con massi erratici e ginepri. La chiazza bianca d’un colimbo in mezzo al bagliore sfaldantesi. Presero a sinistra per una strada di terra da dove si vedeva ancora un lago e nella valletta in fondo alla strada attraversarono un villaggio, poi ripresero a salire per un bosco di pini e abeti con un sottobosco di avellani, e attraverso il bosco arrivarono fin quasi sotto casa.
« Chi potrà rimproverarmi di essere inesatto, chi riconoscerà i luoghi e le persone? Il mio potere è assoluto, adesso là tutto appartiene ad un solo uomo, che un tempo, studente di Vilna, fu trasportato in calesse. E vorrò oppure no dire chi era Wladek, ad esempio, e che prima della guerra mondiale studiava ingegneria a Karlsruhe, o chi era la zia Florentyna, e che al tempo della sua giovinezza un bosco ancora intatto di alberi d’alto fusto formava una parete di tre chilometri di gobbe e declivi fra questo e quell’enorme lago, e che era lei a far venire quei libri francesi con le copertine gialle: Bourget, Gyp, Daudet. Dipende da me cosa scegliere, cosa tralasciare, e mi trattiene solo l’avversione per il fantasticare, quasi credessi che si può rendere fedelmente ciò che è stato. E perché Florentyna? Si fa fatica a prendere coscienza di un fatto nuovo: che adesso mi è permesso di darle del tu, anche se allora non avrei mai osato, e che non è una vecchia dama, ma una fanciulla e una bambina e tutto al tempo stesso. Che mi importa di lei, in busto e tournure, inimmaginabile nei suoi bisogni fisiologici, che accompagnava le figlie a Varsavia, Parigi, Venezia e Biarritz? Ma in fin dei conti è stato proprio il pensiero di lei a introdurmi in questo stato sovrano dell’empiria pura. Di come si adattò al fatto che, invece dell’economo e della servitù, fossero le figlie ad alzarsi all’alba, scarpe alte, pellicce di montone, a mandare i braccianti al lavoro, d’inverno a sorvegliare fino a sera la battitura del grano. E per tre mesi all’anno non era più una tendenza nobiliare di campagna, bensì un pensionato per villeggianti, in cucina da Katreczka il fuoco ardeva dalle quattro del mattino fino a notte e Wladek picchiava sul pianoforte per ore intere, e loro, gli ospiti paganti, ballavano. Era stato necessario accettare anche un silenzioso cambiamento di costumi, diventare indifferenti al fatto che le figlie avessero uomini sposandoli oppure no, e che oltre a Wladek abitasse ora Jerzyk ora qualcun altro. Tutto era come era, non detto, così che la necessaria semplicità trasformava qualsiasi principio ed esigenza in una pretesa degli uomini neutralizzata senza né a né ba. Non si andava in chiesa, se non qualche volta per Florentyna. E lei, con due figlie non molto cattoliche, era il mio pensiero nascosto sulla convenzionalità delle fedi e delle credenze, che non possono resistere alla legge delle cose ».
In effetti, perché a lui, che intesseva quel monologo, non sarebbe dovuto bastare quel che aveva conosciuto là? Allora pensava di essercisi trovato per caso e provvisoriamente, che ciò non fosse che la premessa di qualcosa, ma anche più tardi non ci fu mai nulla oltre alla premessa e al provvisoriamente.Quella stoffa, pelosa, quasi feltro,
Durante tutto il secolo era usata per le vestaglie,
Non potrai perciò distinguere se sia l’inizio o la fine del ventesimo secolo,
Se sedendo davanti allo specchio lei ne scosta un lembo
Giallo-acceso sul rosa-bruno del suo petto.
Né la spazzola che tiene in mano ha mutato forma
E il telaio della finestra può essere di qualunque tempo,
E chi è lei, che abita in quell’unico
Corpo, e in un unico momento?
Da chi qui davvero vista
Se è stato amputato perfino il suo nome?
La sua pelle per nessuno in terza persona,
La sua levigatissima pelle non c’è in terza persona.
Ed ecco che accorre anche una nuvola da dietro gli alberi
Bordata da un bagliore cupreo e tutto ciò
Si immobilizza, si rassoda, entra nella luce.L’aurora delle contrade settentrionali, il canto dei mietitori oltre il lago.
Si muovono lontano, esili, legano gli ultimi covoni.
Quale diritto di immaginarseli mentre tornano al villaggio,
E prendono posto accanto al fuoco, e cuociono, e affettano il pane,
O i loro padri, nelle capanne prima che fosse inventato il camino,
Quando ogni tetto fumigava, come per un incendio,
O tutta questa terra, prima che venisse consegnata ai venti,
Silenziosa, con gli occhi dei laghi nella selva vergine?
E quale diritto di indovinare i successivi levarsi del sole
Sul treno dei prigionieri o sul sonno dei mazzacavalli a torre?
Di nominarsi dio, che guarda dentro alle loro finestre,
Scuote il capo, si allontana, compassionevole, perché sa troppo?
Tu, giovane cacciatore, faresti meglio a dirigere la barca verso l’acqua alta
E a tirar su l’anatra uccisa prima che diventi buio.Nel treno della notte, completamente vuoto, rintronante attraverso i campi, attraverso i boschi, un giovane, l’io di allora, inconcepibilmente identico con me stesso, rannicchia le gambe sulla dura panca, perché nel vagone fa freddo, e sonnecchiando sente lo schiocco degli incroci, l’eco dei ponti, le cadenze delle giunzioni, i fischi delle locomotive. Si sveglia, si strofina gli occhi e vede sulle chiome fuggenti dei pini una distesa in cui arde, in basso, una stella sanguigna.